Pier Toffoletti
Venustas Et Materia
di PIER TOFFOLETTI
preferisco dipingere gli occhi degli uomini piuttosto che le cattedrali,
perché negli occhi degli uomini c’è qualcosa che non c’è nelle cattedrali
Vincent Van Gogh
Ammirando un’autentica opera d’arte non dovrebbe essere determinante conoscere la biografia dell’artista. Il gallo morente, i bronzi di Riace, la Venere di Milo sono opere di ignoti e poco o nulla aggiungerebbe alla loro eccellenza estetica la conoscenza di particolari della vita dei loro autori.
Nel caso di Pier Toffoletti invece l’intreccio tra le sue esperienze di esploratore con i suoi viaggi al centro e agli estremi della terra e dentro la sua coscienza, la sua volontà di penetrazione degli enigmi che ci circondano e le sue poliedriche esperienze creative – dalla comunicazione pubblicitaria alla regia, dalla scultura alla pittura, dallo yoga alla speleologia, dalle emittenti radio alle perlustrazioni di lande desolate – è strettamente avvinto alle forme espressive e alle fasi evolutive della sua arte che da tempo si è fervidamente concentrata sulla pittura.
Pur avendo appreso la disperata inanità della ricerca ultima dell’uomo – inconsapevole creatura, effimero contenitore di energia – Pier Toffoletti è un instancabile quanto temerario indagatore che si appaga di rischiose immersioni nelle viscere della terra e della capacità della sua anima di staccarsi da essa, sapendo trasmettere ai granulosi impasti di marmoree polveri e di sabbie delle sue tavole un’aura di trascendenza con l’ariosa avvenenza delle sue figure dipinte. Stendendo sulle scabrose superfici delle sue tavole inizialmente immagini di vivide resipiscenze classicheggianti, dalle rugginose cromie con predilezione per gli ossidi, l’ocra, la seppia, la sinopia, volgendosi in seguito verso una infinita elegante estensione di grigi e di chiare tonalità, in seguito sopraffati da verdi smeraldo e verdi-azzurri, poi aggrediti da allusive incursioni di blu cobalto e di rossi carminio per ottenebrarsi, nei più recenti lavori, in tetri fondali bituminosi così simili a paurosi anfratti di grotte millenarie in cui si fronteggiano crudamente il bianco e il nero, la luce e il buio, umane sembianze e silenzio di tenebra.
La precocità della pittura in Pier Toffoletti – non ancora tredicenne si cimentava con copie di lavori di Michelangelo e di altri capolavori del Rinascimento – e la sua bramosia di conoscenza per chi siamo, cosa ci sia davvero intorno e dentro di noi, cosa occultino gli abissi, cosa celi la minaccia buia di un antro, vincendo la selvaggia ostilità che ne promana, hanno determinato un crescendo di sedimentazioni interiori, di cognizioni, di stratificazioni emotive che si sono andate via via fissando nella sua copiosa e colta produzione pittorica avvicendatasi nel tempo e presto inghiottita da un mercato di qualità tuttora vitale che spazia dall’Europa all’America fino a raggiungere il raffinato, pretenzioso Giappone.
Un nomadismo istintivo, fisiologico e intimista (“sento che il corpo è un vestito e che in noi c’è qualcosa di più grande che non può morire”), una tensione costante di conoscenza, un amore dichiarato per la bellezza e una innata perizia sono le qualità di Pier Toffoletti per solennizzare l’ambigua gaiezza del vivere, regalandoci inusitati sprazzi di consolazione.
Cui si aggiunge curioso e ammirato stupore per gli esiti così efficaci e ben determinati della sua figurazione, del tutto attuale pur nella sobria classicità di impostazione – e qui sta il prodigio di un’inequivocabile “contemporaneità” espressa con l’eleganza descrittiva di un linguaggio universale ed eterno, con buona pace degli interessati detrattori – mentre, avvicinandosi alle tavole coperte da una sorta di intonaco scabro e abraso cosparso di geroglifici prima impercettibili, si scorgono pochi tocchi di fluide, larghe pennellate, a volte addirittura tracciate con la pennellessa, e confusi addensamenti cromatici che l’inganno della retina, solo riprendendo distanza, ricompone in perfetti contorni di volti, morbidezza di carni, setosità di capigliature, mai disgiunti da un sottofondo velato di malinconia, di dissimulato, pudico struggimento. A rappresentare forse, pur senza ossessione, la fugacità di un istante che ci vide felici, perduto come una canzone portata dal vento.
Giovanni Serafini

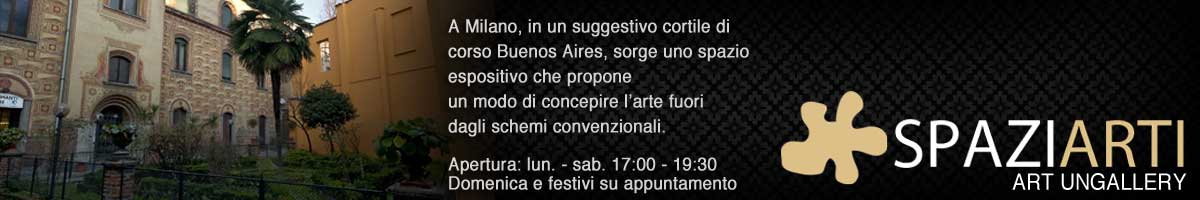




31 Comments
Trackbacks/Pingbacks