Gennaro Solferino
L’artista Solferino comprende che l’opera deve rivolgersi al cuore degli uomini di ogni tempo. Così, la maturazione del suo pensiero lo guida, negli anni sessanta-settanta, a un superamento della propria poetica pittorica, attraverso una decisa svolta verso l’iperrealismo. Che è, per un certo aspetto, appunto stasi temporale. Non pignolesca o maniacale copiatura della realtà, ma piuttosto astrazione della stessa, svuotamento di ogni contenuto. Ed ecco che le sue tele propongono tutta una serie di oggetti metallici, consumistici, oggetti “usa e getta” dei messaggi pubblicitari, immersi in una fredda luce smaltata di uno spazio ricreato: motociclette, barattoli, eccetera, che trasmettono in chi li osserva l’impressione di pure forme atemporali, di “cose” di cui si sia perduto ogni significato. A questo periodo segue un altro. Il più sontuoso dell’arte del Nostro, con opere per la maggior parte di grandi dimensioni, in cui predomina il tema della donna. Una donna per certi versi estranea alla realtà, chiusa in una passività silente, immersa in un’atmosfera rarefatta, ai labili confini del sogno. Si tratta, in genere, di figure femminili, quasi sempre collocate in primo piano e in posizione dominante, su cui si effonde una luce spesso esaltata dal netto contrasto di ombre, in tele d’ispirazione caravaggesca. Sugli sfondi, risolti con piani staccati, – la prospettiva è il più delle volte volutamente assente – si esercita un “continuum” di citazioni pittoriche del passato, in particolare una sentita rivisitazione dell’arte del secolo XIV. A tale proposito, il critico Donato Conenna parla di “macchina del tempo” che cerca un “effetto voragine” che attira irresistibilmente il fruitore in un tempo astorico, in un’illusoria eterna durata. La pittura solferiniana di questo periodo è fatta per lo più di donne e Madonne: conturbanti Madonne terrestri dalla bellezza estatica, esiliate dal cielo e racchiuse nell’incantesimo dell’oro di splendide icone, in cui solo la luce conserva ancora la propria sacralità. Oppure – nell’interessante filone dei bar romani – cortigiane, fatte oggetto di desideri inconfessabili, che portano negli sguardi la loro vicenda di una secolare sottomissione. Donne, queste, che ancora non si sottraggono all’antica corruzione del potere e del denaro, assediate dai vecchi bavosi che le concupiscono e ne comprano i corpi. Ed esse vi acconsentono, non si sa se per avidità o indifferenza o soltanto per rassegnazione, ma al tempo stesso, nonostante il mercimonio che fanno di sé, mostrano rancorose l’eterno trionfo dei loro corpi nudi. Donne e Madonne dagli sguardi intensi che ci agganciano da icone a trittico, da ovali lignei, da tavole contorte e di forma irregolare, da pietre che suggeriscono l’idea di antichi reperti, scampati alla lenta corruzione del tempo, sui quali, per puro miracolo, si è preservata qualche preziosa figura, appena un volto, mentre il resto è andato perduto. Donne e Madonne che ci fissano da un tempo annullato, fittizio, in un’atmosfera onirica in cui il passato emana la sua magia. Un passato che però è nel presente, appunto nel fascino conturbante di quei volti di donna. Il presente non è nulla, sembra affermare l’artista, solo un attimo fuggente. Noi siamo il nostro passato, in noi i secoli si addensano, convivono, come nelle contrade di Puglia le antiche cattedrali e i palazzi di vetro. Ed è per questo che nelle sue donne c’è la storia di tutte le donne, che si dipana da sempre nel labirinto del tempo. Questo sembra dire Ernesto Gennaro Solferino, uomo e pittore della nostra epoca, ma dal volto di antico assiro. Ed ecco una serie di nuove opere, a commento grafico-pittorico dell’Inferno di Dante – che forse apre un diverso interessante periodo della sua arte – tutta ancora da godere e da apprezzare.
FRANCESCO FUMAGALLI.

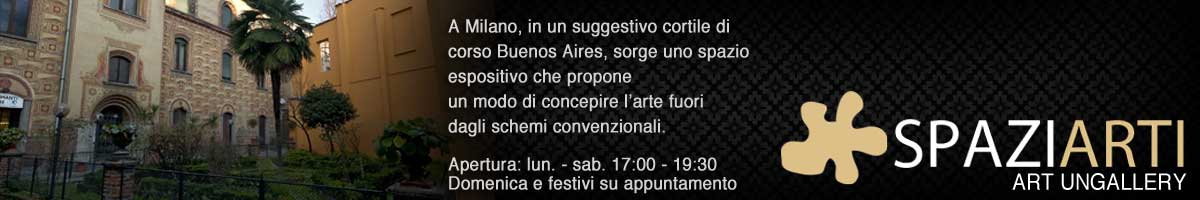




6.333 Comments
Trackbacks/Pingbacks